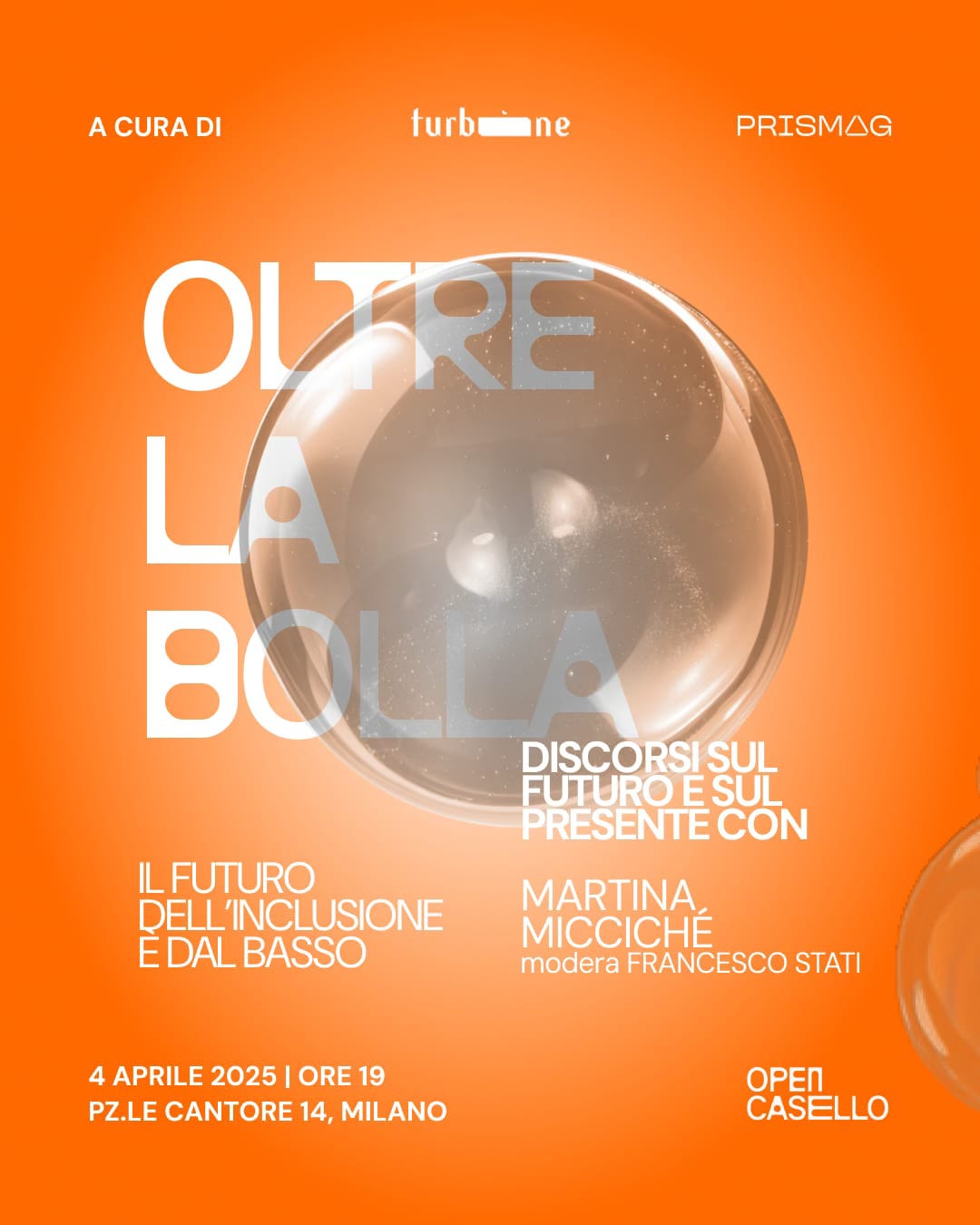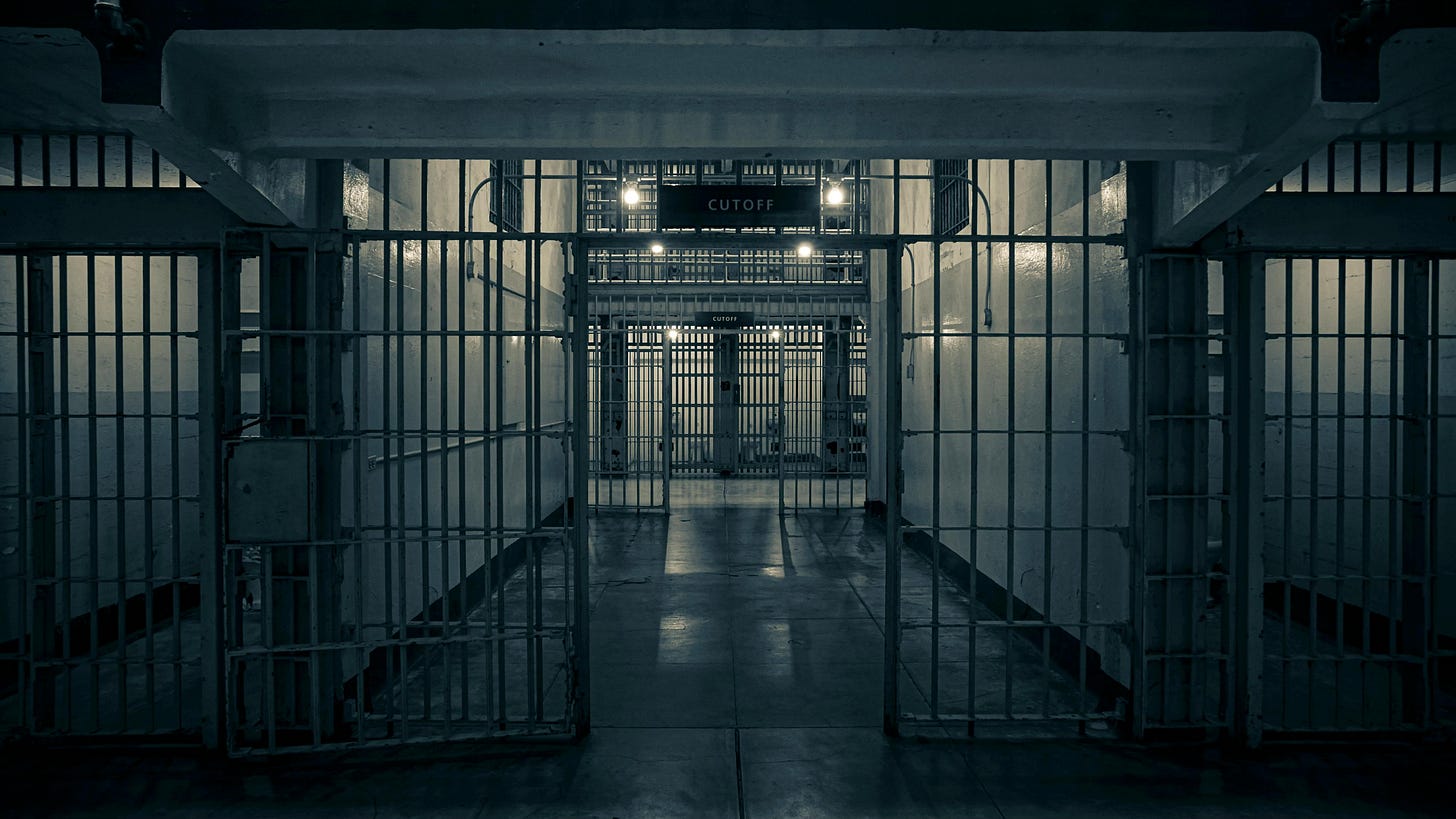Da protezione a punizione
Questa settimana, su Rifrazione, parliamo delle persone transgender nelle carceri italiane e di un nostro evento imminente
In Italia, la popolazione carceraria conta attualmente circa 70 persone transgender, distribuite in sei istituti penitenziari dotati di sezioni dedicate: Rebibbia - Nuovo Complesso (16 detenuti su una capienza di 30 posti), Como (11), Reggio Emilia (11), Napoli Secondigliano (11, di cui 8 nella sezione transgender su 24 posti disponibili), Ivrea (7 su 20 posti) e Belluno (16). Queste persone vivono una “doppia difficoltà”, derivante sia dalla privazione della libertà, sia dall’appartenenza a una minoranza spesso emarginata. Oggi parliamo di loro.
Ma prima, voglio darti qualche novità sul nostro giornale. Il 4 aprile, alle 19, a Milano, negli spazi di Open Casello, parliamo del futuro dell’inclusione con gli amici del magazine Turbìne. Avrò il piacere di parlarne con Martina Micciché, scienziata politica, fotoreporter e scrittrice femminista. Se sei nella City, ci vediamo lì!
Essere transgender nelle carceri italiane: tra isolamento e diritti negati
Le sezioni dedicate alle persone transgender, sebbene istituite per garantire protezione, possono trasformarsi in luoghi di isolamento. Secondo l’associazione Antigone, da sempre attiva per i diritti delle persone detenute, la gestione informale di queste sezioni protette rischia di limitare l’accesso a programmi rieducativi, trasformando una misura protettiva in una condizione punitiva.
La sezione “Orione” di Reggio Emilia, attiva dal 2018, è un esempio di questa contraddizione. Qui, l’offerta di servizi come istruzione, formazione professionale e accesso al lavoro è significativamente inferiore rispetto a quella disponibile per i detenuti maschi. Inoltre, la carenza di personale sanitario compromette la continuità delle terapie ormonali e del supporto psicologico necessari per il percorso di transizione delle persone transgender.
A livello normativo, l’Italia ha compiuto passi avanti nel riconoscimento dei diritti delle persone transgender. Nel 1982, con la legge 164, è stato riconosciuto il diritto al cambio di sesso legale. Tuttavia, nelle carceri, l’applicazione di questi diritti è spesso frammentaria e insufficiente, con una mancanza di linee guida chiare su come gestire le esigenze specifiche delle persone transgender detenute.
Le associazioni attive nel supporto alle persone transgender, come il Movimento Identità Trans (MIT), svolgono un ruolo cruciale nel fornire assistenza e nel promuovere i diritti di questa comunità. Fondato nel 1979, il MIT gestisce un consultorio a Bologna in convenzione con la ASL locale, offrendo supporto legale, psicologico e sanitario. Inoltre, organizza il Festival Internazionale di Cinema “Divergenti”, unico in Italia dedicato alla narrazione dell’esperienza trans.
Un’altra figura di rilievo è Porpora Marcasciano, storica attivista e presidente del MIT. Attraverso le sue battaglie e le sue pubblicazioni, ha portato all’attenzione pubblica temi come il diritto all’identità, all’istruzione e all’occupazione per le persone transgender. Nel 2021, è stata eletta nel consiglio comunale di Bologna, diventando presidente della Commissione Pari Opportunità.
Nonostante gli sforzi delle associazioni e di alcuni istituti penitenziari, la realtà quotidiana delle persone transgender in carcere rimane complessa. La mancanza di formazione specifica del personale penitenziario e l’assenza di protocolli standardizzati possono portare a discriminazioni e a una gestione inadeguata delle esigenze specifiche di queste persone.
Ecco perché i concetti di diversità, equità e inclusione hanno fallito
Negli ultimi decenni diversità, equità e inclusione (DEI) sono diventati principi guida per aziende, governi e organizzazioni internazionali. Tuttavia, oggi emerge un paradosso: nonostante i forti investimenti, questi valori non sono riusciti a diventare realtà socialmente condivisa. La DEI rimane un ideale moralmente valido, ma astratto, incapace di radicarsi nel tessuto quotidiano. Secondo il sociologo Erving Goffman, ogni realtà sociale dipende da frame cognitivi condivisi, che determinano ciò che consideriamo rilevante e come interpretarlo. La DEI non è riuscita a imporsi come frame dominante, restando confinata in contesti istituzionali e richiedendo sempre uno sforzo cognitivo elevato per essere applicata nelle scelte quotidiane.
Questo mancato radicamento deriva dall’incapacità della DEI di diventare una scelta intuitiva, una verità percepita come naturale e immediata, senza bisogno di continue giustificazioni o spiegazioni. Per quanto giusti sul piano etico, i principi della DEI non hanno superato la negoziazione con la realtà pratica, perdendo terreno di fronte a dinamiche più immediate e consolidate, in linea con la teoria dei due sistemi di pensiero di Daniel Kahneman: tendiamo infatti a scegliere automaticamente le opzioni cognitive più semplici e intuitive.
La crisi attuale della DEI non rappresenta un ritorno al passato, bensì il ritorno alla “real reality”, una realtà concreta che non si basa sugli ideali astratti, ma che emerge attraverso il complesso gioco di potere, interessi e percezioni collettive. Proprio come la realpolitik, la real reality non segue ciò che è giusto in teoria, ma ciò che si impone nella negoziazione sociale. Il mancato successo della DEI dimostra che ogni idea, anche la più giusta, deve conquistare consenso attraverso la legittimazione condivisa, superando le barriere della percezione collettiva e del costo cognitivo.
Per approfondire questa storia, leggi l’articolo di Matteo Flora sul nostro sito.
Le lotte di tutti
E anche per questa settimana io ti ho detto tutto. Trovi il nostro numero sull’intersezionalità nel nostro shop: la copertina è bellissima, quello che c’è dentro ancora di più. Invece, qui trovi i nostri podcast. La scorsa settimana è uscita la prima puntata di This Parità, con un’ospite d’eccezione: la giornalista Alessia Tarquinio. Continua a supportarci e sarà solo la prima di tantissime puntate: alcune sono già in lavorazione!
Noi ci sentiamo la prossima settimana.